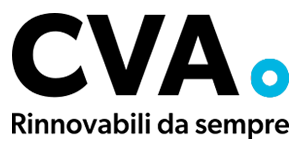Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è intervenuto al Convegno in onore di Stefano Micossi “Italia: riprendere il filo della crescita”, organizzato da Assonime e LUISS Guido Carli. Riportiamo di seguito il suo intervento integrale.
“Sono particolarmente lieto di partecipare a questo convegno in onore di Stefano Micossi, cui da cinquant’anni mi lega un’amicizia iniziata con la nostra assunzione in Banca d’Italia, giovani vincitori nel 1972 di borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher e Giorgio Mortara. Ringrazio quindi gli organizzatori per il gradito invito, che mi offre anche l’opportunità di discutere di economia e di politica economica con uno sguardo al futuro, rivolto verso i più giovani.
Per valutare le risorse e le politiche necessarie per affrontare tempi oggi così incerti, può essere utile partire da una breve sintesi degli straordinari cambiamenti osservati in questi ultimi cinquant’anni. Se, seguendo Carlo M. Cipolla, ogni situazione storica rimane unica ed irripetibile, dalle esperienze passate è tuttavia possibile trarre qualche lezione utile per il presente. Una comprensione adeguata di come si è andata determinando la realtà che oggi viviamo, in particolare, può servire soprattutto ad aiutarci per evitare gli errori del passato e a riflettere su come meglio prepararci per affrontare le sfide che abbiamo davanti, come ridurre l’incertezza e, soprattutto per i più giovani, i costi della transizione a nuovi “equilibri”, nuove “normalità”, dopo crisi finanziarie, pandemie e persino guerre che ritenevamo non più ripetibili.
E una delle principali lezioni di questi ultimi anni è forse proprio che “equilibri” e “normalità”, se costituiscono utili termini di riferimento sul piano analitico, sono però concetti effimeri nel tempo storico. I fenomeni da comprendere e approfondire per costruire un futuro sicuro, sostenibile e prospero sono proprio i continui cambiamenti e i gravi squilibri che hanno segnato e continuano a segnare il tempo che abbiamo vissuto e gli anni che oggi viviamo. In una fase come quella attuale dobbiamo soprattutto sottolineare l’importanza per i giovani cittadini di oggi di essere preparati, anzitutto sul piano culturale, per fare fronte agli imprevisti del presente e alle incognite di un futuro anche prossimo, che appaiono e sono forse maggiori di quanto apparissero nei giorni della nostra giovinezza. Ma, oltre alle risorse “culturali” occorre anche potenziare, oggi, le risorse “economiche” ed “istituzionali”, perché i giovani possano, prendendo a prestito le parole di Amartya Sen, “fare ed essere” ciò che ritengono importante nella vita.
L’evoluzione dell’economia e della demografia mondiale
Negli anni Settanta del Novecento, nel pieno della Guerra fredda, il mondo si presentava diviso in blocchi: ai paesi occidentali si contrapponevano i paesi del “socialismo reale”; vi era poi il “terzo mondo”, ossia i paesi in via di sviluppo, che potevano fare riferimento al Movimento dei paesi non allineati, sorto negli anni Cinquanta per iniziativa di Egitto, India e Jugoslavia, con la Cina come osservatore. Date le forti divisioni, gli scambi erano modesti: il valore del commercio di beni e servizi era pari al 13 per cento del PIL mondiale nel 1972, meno della metà di oggi. E ben inferiori rispetto ai nostri giorni erano i movimenti di persone nel mondo: per i voli in aereo dai 350 milioni di passeggeri di allora siamo passati agli oltre 4,5 miliardi del 2019.
Ciò non significa che non vi fossero iniziative multilaterali, anche tra i due blocchi contrapposti. Possiamo ricordare, ad esempio, che i primi oleodotti dall’Unione Sovietica all’Europa occidentale nacquero negli anni Sessanta, mentre la costruzione dei gasdotti dalla Siberia si intensificò durante gli anni Ottanta. Nella seconda metà degli anni Sessanta, nella cosiddetta Togliattigrad, nei pressi del Volga, la FIAT cooperava con la russa VAZ per la produzione di automobili (come quella nota come Zigulì, una versione modificata della FIAT 124).
Il pianeta contava 3,8 miliardi di persone nel 1972, meno della metà dei quasi 8 miliardi di oggi. I residenti di un paese nati in un altro paese erano, a livello globale, 78 milioni, appena un terzo rispetto agli ultimi anni. Per oltre il 90 per cento l’aumento della popolazione è avvenuto nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Cinquant’anni fa i residenti in Italia erano 54 milioni e, dal nostro paese, emigravano più persone di quante ne arrivassero dall’estero; la popolazione, dopo aver raggiunto un picco di quasi 61 milioni nel 2014, con un incremento appena superiore al 10 per cento, è poi ridiscesa a meno di 59 milioni, il valore stimato alla fine dello scorso anno (dall’1,42 per cento della popolazione mondiale nel 1972, allo 0,75 di oggi). Ricordiamo inoltre le previsioni di una ulteriore forte discesa nei prossimi decenni (sotto i 50 milioni entro il 2060), in particolare per le coorti formate da persone in età da lavoro.
A fronte della crescita demografica, anche quella economica è stata più sostenuta nei paesi emergenti e in via di sviluppo. A livello globale il prodotto pro capite è aumentato del 150 per cento negli ultimi cinquant’anni, del 400 per cento nei paesi asiatici. E il peso dell’Italia sull’economia mondiale è passato da quasi il 5 a meno del 2 per cento.
Il marcato miglioramento nelle condizioni di vita derivato dalla crescita economica mondiale è ben visibile in numerosi indicatori, quali la speranza di vita (o vita media alla nascita), salita di ben 13 anni a livello globale, a quasi 73 anni; la mortalità infantile, scesa dal 100 a meno del 30 per mille; il numero di persone in condizioni di povertà estrema (definita da un reddito o una spesa per consumi minore di 1,9 dollari al giorno ai prezzi del 2011), diminuito da un picco di oltre due miliardi raggiunto attorno al 1970, mantenutosi fino ai primi anni Novanta, a meno di 700 milioni (e oltre 4 miliardi di nuovi abitanti non vi sono entrati).
I progressi hanno avuto effetti pervasivi anche nella vita di tutti i giorni. Dal 1991 la diffusione di Internet e della telefonia mobile hanno cambiato le modalità di comunicazione e hanno abbattuto i suoi costi: quando eravamo studenti le telefonate da o verso l’estero erano spesso collect calls (a carico del destinatario), perché pochi, non solo giovani, potevano permettersi gli oneri delle chiamate; stimare anche una sola equazione era un esercizio complesso e per i modelli econometrici le stime venivano sovente fatte di notte per risparmiare sui costi degli elaboratori elettronici, computer spesso grandi quanto una stanza e migliaia di volte meno potenti di un moderno PC o di uno smartphone; le automobili erano molto meno sicure, non solo senza airbag, ma anche senza cinture di sicurezza e spesso senza specchietti (in Italia divenuti obbligatori solo nel 1977).
Per Leibniz natura non facit saltus, la natura non fa salti, ma è certo che i cambiamenti sono stati straordinari e, nonostante lo “sconvolgimento demografico”, in complesso positivi per l’economia mondiale. Come dirò vi sono state, però, delusioni anche gravi e i benefici non sono stati, in ogni caso, sufficientemente diffusi.
Dalla caduta del regime di Bretton Woods alla “grande inflazione”
I cambiamenti nell’economia mondiale non sono avvenuti solo a causa della rapidità dello sviluppo. Proprio gli anni Settanta si sono infatti aperti con due avvenimenti che hanno profondamente mutato il contesto economico globale.
Il 15 agosto del 1971 il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annunciò la sospensione della convertibilità del dollaro con l’oro, ponendo fine al sistema di cambi fissi istituito con gli Accordi di Bretton Woods del 1944. Tale sistema, prevenendo ogni tentativo di porre in atto svalutazioni competitive, aveva favorito anni di stabilità monetaria e di sviluppo economico. La decisione di Nixon fu innescata dalle intenzioni dei governi di Francia e Regno Unito di richiedere la convertibilità dei dollari in oro, ma trova le sue radici più profonde nelle difficoltà, esacerbate dai costi della guerra in Vietnam, di attuare politiche di bilancio e monetarie coerenti con il mantenimento di un tasso di cambio fisso. Quel sistema lasciò così il posto all’attuale “non-sistema”, determinato dalla decisione dei principali paesi di far fluttuare liberamente il valore delle proprie valute, al fine di recuperare un più pieno controllo delle politiche di bilancio e monetarie (e ricordiamo anche le conseguenze, non positive, per il cambio della lira).
Appena due anni dopo la fine del regime di Bretton Woods, lo shock petrolifero del 1973, causato dall’embargo imposto dai paesi dell’OPEC a seguito della guerra dello Yom Kippur scoppiata nell’ottobre di quell’anno, ebbe non solo conseguenze molto pesanti sull’economia mondiale, spingendo molti paesi avanzati in recessione e portando l’inflazione su livelli altissimi; esso contribuì anche a rivoluzionare l’analisi economica e, in particolar modo, i principi che guidavano la conduzione della politica monetaria.
La crescita dei prezzi al consumo, innescata ovunque dai rincari del greggio fu un fenomeno globale. In poco più di un anno il prezzo del petrolio quadruplicò; sarebbe ulteriormente triplicato con il secondo shock petrolifero dopo la rivoluzione in Iran del 1979. Nel corso del 1974 e del 1975 l’inflazione superò il 20 per cento in Giappone, Italia e Regno Unito e andò ben oltre il 10 per cento negli Stati Uniti e in Francia. Da noi negli anni seguenti il rientro dell’inflazione fu modesto e di breve durata; nel 1980 tornò a superare il 20 per cento e solo dalla metà degli anni Ottanta, beneficiando degli effetti del “controshock” petrolifero del 1985-86, ritornò a una cifra, mantenendosi però, fino al 1992, attorno a un livello medio compreso tra il 5 e il 6 per cento, valori superiori a quelli registrati negli altri principali paesi europei.
I fattori che, assieme al petrolio, contribuirono ad alimentare l’inflazione, furono diversi tra paesi, così come diverse furono le risposte delle politiche economiche, determinando percorsi di rientro molto differenti. Negli Stati Uniti una progressiva perdita di controllo della crescita dei prezzi ebbe inizio già dalla seconda metà degli anni Sessanta una politica di bilancio particolarmente espansiva per far fronte ai costi della guerra in Vietnam e introdurre le riforme previste dal piano Great Society era stata sostanzialmente “accomodata” da parte della Riserva federale, con un graduale disancoraggio delle aspettative d’inflazione. La disinflazione fu attuata con una politica monetaria fortemente restrittiva (la Volcker disinflation), cui seguì una doppia recessione nel periodo 1980-1982, con il tasso di disoccupazione che sfiorò l’11 per cento nel 1982. Alla fine di quell’anno, favorita anche dall’avvio di una fase di apprezzamento del dollaro, l’inflazione tornò sotto il 4 per cento.
In Germania la Bundesbank adottò un approccio più restrittivo fin dal crollo del regime di Bretton Woods, cui seguì un deciso apprezzamento del marco in termini effettivi, e nel 1973 dichiarò che il contrasto alla crescita dei prezzi costituiva il principale obiettivo della politica monetaria; dalla fine del 1974, prese ad annunciare un obiettivo in termini di tasso di espansione della quantità di moneta, un’àncora nominale che costituì un riferimento essenziale per l’economia e contribuì (in assenza di meccanismi di indicizzazione salariale) a contenere la crescita sia dei salari sia dell’inflazione attesa. Quella effettiva rimase così al di sotto dell’8 per cento durante il primo shock petrolifero, tornando prossima al 2 per cento già nel 1978. Con il secondo shock petrolifero raggiunse un picco del 7,5 per cento nell’ottobre 1981, per ridiscendere molto rapidamente nei mesi successivi: agli inizi del 1983 era tornata sotto al 4 per cento e, nel 1984, oscillava già attorno al 2 per cento.
In Italia il perdurare dell’alta inflazione durante gli anni Settanta, e oltre, dipese, oltre che dal petrolio, da tre principali fattori. Un ruolo cruciale fu svolto dalla indicizzazione dei salari, portata in media al 100 per cento nella seconda metà degli anni Settanta, con una vana quanto pericolosa rincorsa tra salari e prezzi (accentuata per “riaprire” il ventaglio salariale continuamente ridotto dall’operare del “punto unico di contingenza”, con “scatti” uguali per tutti i salari) che certo non era in grado di annullare la cosiddetta “tassa dello Sceicco”. In secondo luogo, l’inflazione fu sospinta dalla politica di bilancio eccezionalmente espansiva, con il debito pubblico che salì da meno del 40 per cento del PIL nel 1970 al 60 per cento verso la fine di quel decennio; fino al “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia, in un contesto di assenza della necessaria autonomia quest’ultima dovette contribuire al finanziamento del bilancio acquistando i titoli rimasti invenduti nelle aste dei titoli di Stato, offerti peraltro a tassi d’interesse largamente inferiori all’inflazione (che quindi si aggiungeva, come tassa, alle “normali” entrate tributarie). Infine, l’instabilità del cambio si riflesse in un deprezzamento della lira, nel quadriennio 1973-1976, non solo di oltre il 30 per cento nei confronti del dollaro, ma anche del 50 per cento rispetto al marco tedesco e del 35 rispetto al franco francese, con una forte spinta all’inflazione “importata”. Mancavano, in quegli anni, tutti gli elementi chiave che il Governatore Ciampi, nelle sue Considerazioni finali del 1981, individuò come fondamentali per il ritorno alla stabilità della moneta: “autonomia della banca centrale, rafforzamento delle procedure di bilancio, codice della contrattazione collettiva”.
A frenare il rientro dall’inflazione nel corso degli anni Ottanta contribuì la spinta sulla domanda aggregata proveniente dal ricorso prolungato al debito pubblico, che arrivò a superare il 100 per cento del PIL nel 1992 (nel 1990 secondo i dati disponibili all’epoca). Al venir meno della “tassa da inflazione” non corrisposero infatti né una revisione della variazione tendenziale della spesa pubblica, né una sostituzione con altre entrate d’imposta. L’indicizzazione salariale, pur ridotta negli anni Ottanta, rimase, de jure e de facto, troppo elevata: per accomodare l’aumento dei prezzi al consumo – che si originava soprattutto nel settore dei servizi (in larga parte “protetti” dalla concorrenza) a causa della loro bassa produttività – il costo del lavoro crebbe in misura non sostenibile per le imprese industriali aperte alla concorrenza internazionale. La perdita di competitività accumulata in seguito ai differenziali di inflazione, e accentuata anche dalla politica monetaria restrittiva attuata in Germania a seguito della riunificazione tedesca, portò alla grave crisi economica e finanziaria del 1992-93, con la sospensione della partecipazione della lira agli accordi di cambio europei e la sua forte svalutazione.
Il ritorno della crescita dei prezzi sui valori dei nostri principali partner commerciali avvenne nel corso degli Novanta. Un fattore decisivo fu certamente la caduta della domanda a seguito della crisi, che contribuì anche a consolidare i guadagni di competitività (le partite correnti della bilancia dei pagamenti tornarono in surplus, dopo due decenni di deficit). Ma determinante fu il verificarsi dei tre elementi chiave individuati da Ciampi nel 1981. La politica monetaria mantenne un’intonazione restrittiva, anche grazie alla ritrovata autonomia della Banca d’Italia, prima con il “divorzio” del 1981, poi, all’inizio degli anni Novanta, con l’assegnazione esclusiva al Governatore della responsabilità di variare il tasso di sconto e con l’eliminazione dello scoperto di conto corrente del Tesoro. Riguardo alla politica dei redditi (il “codice della contrattazione collettiva”), proprio alla vigilia della crisi, nel luglio 1992, fu abolita la scala mobile e l’anno successivo fu definito un nuovo modello contrattuale che stabilì, tra l’altro, che la contrattazione doveva avere come riferimento l’inflazione programmata fissata dal Tesoro. Quanto alla politica di bilancio, i Governi succedutisi in quegli anni perseguirono una graduale riduzione del debito pubblico, salito fino al 120 per cento del PIL nel 1994, con misure volte, dal 1995, a ottenere un avanzo primario sufficientemente elevato. I successi così conseguiti sul fronte dell’inflazione e delle finanze pubbliche furono coronati, il 1° gennaio 1999, con l’ingresso del nostro paese nell’area dell’euro.
La globalizzazione, la rivoluzione informatica e gli squilibri connessi
Negli anni Novanta, anche grazie alla fine della Guerra fredda, si sono verificati altri due grandi cambiamenti a livello mondiale. Il primo è l’intensificazione del processo di integrazione dei mercati, concretizzatosi nella forte crescita degli scambi commerciali internazionali e degli investimenti su scala globale. Il secondo è l’accelerazione del progresso tecnologico, su cui hanno influito dapprima la cosiddetta rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e, negli anni più recenti, la digitalizzazione. Ne sono stati favoriti non solo i movimenti tra paesi di persone, beni, servizi e capitali finanziari, ma anche lo scambio e la diffusione di idee, informazioni, tecniche di produzione, contribuendo a determinare i miglioramenti nelle condizioni di vita a livello globale.
Questi sviluppi, che hanno avuto luogo in modo pressoché non governato, non sono tuttavia stati privi difficoltà, senza che vi seguisse una pronta risposta da parte delle politiche economiche. Ne sono così derivati squilibri di varia natura, a livello globale, europeo e nazionale, e una sostanziale delusione delle aspettative che negli anni Novanta avevano accompagnato la fine della Guerra fredda e la progressiva e impetuosa apertura dei mercati e connessa liberalizzazione degli scambi.
Innanzitutto vi è stata una crescita, in molta parte non controllata, della finanza privata, che ha portato agli eccessi – la bolla immobiliare registrata negli Stati Uniti a metà degli anni 2000 alimentata da politiche imprudenti nella concessione del credito e la diffusione di prodotti opachi e complessi della finanza strutturata – culminati nella crisi finanziaria globale del 2008-09.
Assai rilevanti sono stati poi costi ambientali. Sebbene i legami tra le condizioni climatiche, le emissioni di gas serra e le attività di produzione e di consumo fossero noti da tempo, la concentrazione di gas serra ha continuato a salire a ritmi preoccupanti e richiede, oggi, una risposta urgente.
Sul piano sociale, la crescita dei paesi emergenti e in via di sviluppo, assai più rapida di quella dei paesi avanzati, ha ridotto i divari di reddito “tra paesi” e la disuguaglianza a livello globale ma, al contempo, è cambiata la distribuzione dei redditi “all’interno” dei singoli paesi, in generale nella direzione di un aumento delle disparità. La disuguaglianza mondiale si è così “internalizzata”: a una minore distanza di reddito tra americani e cinesi si è in parte sostituito un forte allargamento dei divari tra i ricchi e i poveri sia negli Stati Uniti (e in altri paesi avanzati) sia in Cina. In particolare, nel mondo “occidentale” è – come si dice oggi – “entrata in affanno” la classe media.
L’aspetto più grave di questo problema è che, nei paesi avanzati, l’aumento delle disuguaglianze si è accompagnato a una minore capacità dei figli di passare a uno status sociale diverso da quello dei genitori, riducendo il cosiddetto grado di mobilità sociale inter-generazionale. Da un lato, i figli dei ricchi e super ricchi tendono a rimanere tali nel tempo; dall’altro, per i figli di chi proviene dei ceti meno abbienti sembra essere arduo migliorare la propria posizione sociale. Sono aspetti che vanno oltre la sola sfera dell’etica: il conseguimento di una mobilità sociale elevata sarebbe infatti un’indicazione che il destino delle nuove generazioni non è segnato dalla nascita e che competenze, merito e impegno contano; essa costituirebbe quindi uno stimolo importante per l’intraprendenza delle persone e per uno sviluppo economico e sociale equilibrato e duraturo.
Diversi sono gli squilibri emersi anche a livello europeo. In primo luogo, i ritardi accumulati rispetto agli Stati Uniti sul fronte della capacità delle imprese di innovare, capacità che costituisce il principale motore per lo sviluppo economico. In secondo luogo, gli “eccessi di mercantilismo”, con la Germania che dal 2012 al 2021 ha mantenuto un surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti pari in media a quasi l’8 per cento del PIL, forse uno dei più rilevanti squilibri anche a livello globale. In terzo luogo, la concentrazione della dipendenza energetica, un problema venuto alla luce drammaticamente nell’ultimo anno, ma la cui rilevanza era stata discussa già dagli Sessanta, durante la costruzione degli oleodotti e gasdotti dall’Unione Sovietica, che aumentarono significativamente il peso degli approvvigionamenti di materie prime energetiche dai paesi che ne facevano parte, Russia in primis.
Vi è poi la questione dell’incompletezza della costruzione europea. L’introduzione dell’euro è stata un passo fondamentale del cammino verso l’integrazione tra le nazioni dell’Unione europea e un elemento chiave per la stabilità monetaria e finanziaria del nostro continente. Ma l’assenza di un bilancio comune e di chiari progressi nella direzione, certo più complessa, dell’unione politica – assenze che rendono l’euro una “moneta senza Stato”, come la definì Tommaso Padoa-Schioppa – costituiscono due elementi di fragilità fondamentali, che non potranno non essere affrontati nel corso dei prossimi anni.
Così come devono essere affrontati, nel nostro paese, i numerosi fattori di debolezza che hanno portato, negli ultimi trent’anni, a una crescita economica insufficiente. Sulla rilevanza di molti di questi fattori vi è oramai un consenso ampio, anche se permangono forti resistenze nell’affrontare i problemi, spesso a causa del prevalere di interessi contrapposti, i “lacci e lacciuoli” di cui già parlava Guido Carli nei primi anni Settanta.
L’Italia, tra oggi e domani
L’Italia è da troppi anni caratterizzata da un “eccesso di debito” pubblico e da una contemporanea “carenza di Stato”: a fronte di un indebitamento troppo elevato, pesante eredità degli squilibri passati, l’efficienza dei servizi pubblici e, più in generale, l’efficacia dell’intervento dello Stato nell’economia stentano a migliorare. Sono inoltre rilevanti gli ostacoli al buon funzionamento dei mercati, senza per questo abbandonarsi a un pernicioso laissez-faire, in particolare nel settore dei servizi, dove, nonostante alcuni progressi, sono ancora presenti barriere che riducono significativamente la concorrenza. A dispetto di decenni di politiche a favore del Mezzogiorno, il suo divario di sviluppo nei confronti del Centro Nord continua ad aumentare: esso riflette, oltre all’inefficacia dell’azione pubblica, il basso peso e i ritardi del settore produttivo privato; vi incide pesantemente il radicamento sul territorio delle organizzazioni criminali che, oltre ai gravi costi sociali, impone alle imprese oneri spesso insostenibili e falsa il funzionamento del mercato e le dinamiche concorrenziali.
A questi nodi da tempo irrisolti, negli ultimi anni si sono affiancate nuove questioni, in particolar modo quelle legate al ristagno della produttività, pressoché ferma ormai da tre decenni in Italia, che trova le sue radici nella difficoltà del sistema produttivo ad adattarsi ai grandi cambiamenti degli anni Novanta.
La globalizzazione e l’affermazione delle nuove tecnologie hanno infatti messo in luce rilevanti debolezze del nostro settore privato, che è rimasto sbilanciato verso imprese piccole e molto piccole che dispongono di pochi mezzi, sia finanziari sia in termini di competenze manageriali, per trarre pieno beneficio dalle nuove tecnologie e per effettuare quegli investimenti in ricerca e sviluppo oggi indispensabili per innovare. La specializzazione settoriale, rimasta orientata verso i comparti tradizionali, ha poi esposto il paese alla crescente concorrenza dai paesi emergenti e in via di sviluppo. Nel corso degli anni Novanta, anche per far fronte a una disoccupazione elevata e in aumento, si è puntato – con soluzioni in ultima istanza, in assenza di adeguati investimenti innovativi, essenzialmente miopi – su riforme tese soprattutto a contenere i costi del lavoro; è così aumentato il ricorso a forme contrattuali temporanee e precarie, che hanno penalizzato le fasce più deboli delle forze lavoro, come i giovani neo assunti e gli occupati meno istruiti. Gli investimenti, pubblici e privati, sono invece stati ampiamente insufficienti, con effetti negativi su produttività e competitività.
Ha inoltre assunto un ruolo primario il divario rispetto agli altri paesi sul piano dell’istruzione, un fattore chiave nelle moderne “economie della conoscenza”. La quota di popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio di livello terziario vede l’Italia al penultimo posto fra i paesi dell’OCSE (con il 28 per cento, a fronte di una media del 45, con valori che superano il 60 per cento in Canada, Giappone e Corea del Sud). Resta alta l’incidenza di giovani che, nella stessa fascia di età, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore (il 24 per cento, contro il 15 della media OCSE). A causa anche dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile, ne deriva che il nostro paese è tra quelli con la più elevata percentuale di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione: sono oltre 2 milioni di persone tra i 15 e 29 anni, il 22 per cento della popolazione in questa fascia di età (il 33 per cento nel Mezzogiorno).
Di questi ritardi ho discusso più volte. Su di essi pesano un insufficiente riconoscimento, non solo economico, della rilevanza dell’istruzione, l’esiguità delle risorse investite (pubbliche e private) e la scarsa varietà dei percorsi formativi offerti dopo il diploma.
Alcune conclusioni
Per affrontare molti di questi problemi, un ruolo importante è assegnato, in Italia, ai progetti e alle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con le sue ingenti dimensioni finanziarie, che beneficiano di trasferimenti e prestiti dall’Unione europea a condizioni molto favorevoli, esso segna una netta discontinuità nella definizione delle politiche economiche, delineando una strategia che coniuga programmi di investimenti pubblici, di incentivi agli investimenti privati e di riforme. Esso offre la possibilità di colmare parte notevole dei ritardi accumulati nelle infrastrutture materiali e immateriali, di potenziare il sistema della ricerca, di migliorare quello educativo. La sua attuazione nei prossimi anni deve costituire un obiettivo primario e sarà decisiva per superare le debolezze che rallentano la crescita della nostra economia. Eventuali adattamenti del Piano potranno avere luogo per affrontare difficoltà, quali quelle connesse con il rincaro dei beni energetici, senza tuttavia rivederne le linee strategiche e intervenendo, come sta già avvenendo, con specifici stanziamenti.
Nell’area dell’euro è prioritario vincere, al più presto e limitando quanto più possibile i danni, la battaglia contro l’inflazione. La stabilità monetaria è infatti un obiettivo di politica economica cruciale nella promozione di uno sviluppo economico favorevole a chi è ai primi passi nel mercato del lavoro. Proprio l’esperienza della “grande inflazione” degli anni Settanta ci rammenta le difficoltà e i gravi costi, economici e sociali, che comporta la perdita del controllo della crescita dei prezzi. E ci ricorda l’importanza, per evitare questo scenario, di prevenire l’avvio di spirali salari-prezzi e il disancoraggio delle aspettative di inflazione. Come per la “tassa dello sceicco” degli anni Settanta, lo shock energetico in corso costituisce un onere ineludibile per il Paese: oggi come allora il tentativo di annullarne l’impatto sui redditi nominali e quindi sul costo del lavoro finirebbe inevitabilmente per ripercuotersi sui prezzi, alimentando una vana quanto dannosa rincorsa.
La politica di bilancio può invece ridistribuirne gli effetti tra famiglie, fattori di produzione, generazioni presenti e future, con interventi, mirati e di natura temporanea a favore delle famiglie e delle imprese più colpite, che possono contribuire anche a ridurre le pressioni per incrementi salariali. Nel caso si scegliesse la redistribuzione intertemporale, finanziandola con l’emissione di debito pubblico, bisogna fare attenzione a non caricare oneri ingiusti sulle generazioni future. Ricordiamoci invece di quanto sia ancora essenziale riavviare – anche con interventi sulla struttura dell’economia volti a favorire la crescita qualitativa e dimensionale delle imprese e la partecipazione dei giovani e delle donne al lavoro (tanto più necessaria alla luce delle avverse tendenze demografiche) – l’ascensore sociale e promuovere l’uguaglianza delle opportunità.
La crisi innescata dall’aggressione russa dell’Ucraina accresce inoltre l’esigenza di accelerare la transizione verde, riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, diversificando gli approvvigionamenti, innalzando l’efficienza nell’uso di energia e, soprattutto, il ricorso a fonti rinnovabili. Non va però dimenticato, specialmente per il nostro paese, “il triangolo” che per Ciampi figuratamente racchiudeva gli elementi necessari per la stabilità monetaria e che, oltre all’autonomia della banca centrale e alla coerenza dei comportamenti che regolano la dinamica dei redditi, richiede la massima responsabilità e attenzione all’equilibrio delle finanze pubbliche.
A livello internazionale la globalizzazione e il progresso tecnologico hanno avuto indubbi benefici. Sarebbe quindi sbagliato rinunciarvi. Occorre però adoperarsi affinché tali benefici siano più diffusi, intensificando l’impegno per sostenere chi rischia di rimanere indietro o ha più difficoltà ad adattarsi. Non si può, in ogni caso, abbandonare la cooperazione internazionale: le sfide vecchie e nuove – dall’eradicazione della povertà estrema al contenimento del cambiamento climatico e alla difesa contro le pandemie – non si affrontano con un ritorno a nazionalismi e a un mondo diviso in blocchi. Un grande sforzo è necessario: non si può non riconoscere come il conflitto in Ucraina stia mettendo a repentaglio l’assetto economico e finanziario emerso dalla fine della Guerra fredda.
Ai più giovani, cui questo intervento è rivolto, non posso non ribadire che il fattore cruciale per affrontare con successo le sfide poste dai cambiamenti che stiamo vivendo resta quello del capitale umano e quindi dell’istruzione. Istruzione che non dovrà essere limitata a quanto (e come) si apprende sui banchi di scuola o all’università, ma che dovrà essere alimentata lungo tutto il nostro arco di vita, beneficiando dell’incontro tra la cosiddetta cultura “umanistica” (dalla conoscenza della storia alla capacità di espressione), da valorizzare, e quella “tecnico-scientifica”, su cui investire.
E sarà necessario acquisire sempre più “nuove competenze”, essenziali per far fronte con successo a situazione spesso inedite e non di routine: dall’esercizio del pensiero critico (possiamo aggiungere, oggi, contro le fake news e senza esitare ad approfondire quanto solo veicolato nei social media) all’attitudine a risolvere problemi, dalla creatività alla disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione. Newton riteneva che “ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano”. Per affrontare l’incertezza sistemica dei nostri giorni, l’investimento in conoscenza – la cui importanza è un precetto che ci è stato trasmesso nei secoli – sarà il fattore chiave, così come per favorire lo sviluppo economico e costruire una società più giusta.