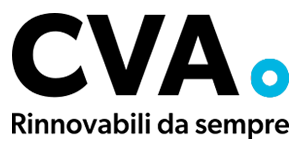Tra gli aspetti della relazione terapeutica che la pandemia ci ha costretto a rimettere in discussione il più visibile è il distanziamento. I medici e gli altri professionisti della cura hanno dovuto, per evitare i contagi, paludarsi con scafandri e maschere, tanto da presentarsi ai malati con tenute assolutamente inedite. Anche i medici che in passato dovevano affrontare epidemie contagiosi si distanziavano. Pensiamo a come sono stati rappresentati i medici della peste: con stivali, palandrane e soprattutto maschere con il lungo becco, dentro il quale si munivano di erbe profumate e della miscela chiamata teriaca, alla quale erano attribuite facoltà miracolistiche. In mano tenevano un bastone, a quanto pare per tener lontani gli appestati. Per quanto spettacolare il distanziamento del passato, niente a confronto di quello richiesto dal covid 19. Almeno là dove i dispositivi di sicurezza sono stati effettivamente resi disponibili.
Questa situazione ha costituito un problema per i clinici. Ci riferiamo a quelli che, pur valorizzando la tecnologia che la medicina dei nostri giorni mette loro a disposizione, non hanno mai abbandonato la relazione di cura che passa per i cinque sensi. Per rendersene conto è istruttivo ascoltare l’esperienza di medici che sono stati in prima linea e l’emergenza l’hanno vissuta in pieno. Li incontriamo nelle pagine di un libro appena edito dal Pensiero Scientifico: Abbracciare con lo sguardo. Lo hanno scritto, alternando voci ed esperienze, quattro medici che durante l’emergenza sono stati in servizio nell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: Michela Chiarlo, Francesca Bosco, Davide Tizzani e Federica Zama Caviccchi.
Lontano dall’enfasi retorica con cui il lavoro di medici e infermieri è stato celebrato come eroismo, raccontano sobriamente, con parole e immagini – le foto di cui il libro è corredato sono altrettanto eloquenti – lo svolgersi quotidiano delle cure erogate ai malati: casi clinici esemplari, decisioni difficili, emozioni estranee al loro lavoro routinario in ospedale.
Ma è soprattutto il titolo che hanno voluto dare al libro a introdurci nel più profondo del loro vissuto. “Abbracciare con lo sguardo” riesce a dare corpo alla sfida più difficile che hanno dovuto affrontare: trovare modi inediti per essere vicini ai pazienti che accanto a loro erano chiamati ad affrontare una malattia nuova e imprevedibile negli esiti di vita o di morte – “uno sarà preso e l’altro sarà lasciato”, verrebbe da commentare con le parole evangeliche che evocano uno scenario apocalittico, i cui non ci è dato di riconoscere i criteri della scelta – senza essere attrezzati. Mancava non solo la strumentazione tecnica, ma anche quel sapere che si appoggia sulle conoscenze scientifiche. Di fronte alle domande più dirette (“Quante probabilità ho di risvegliarmi dall’intubazione?”) i nostri urgentisti sono consapevoli di non essere in grado di rispondere con parole oneste.
Privati in più della risorsa più fondamentale: la vicinanza fisica al malato. Si presentano bardati – cuffia, calzari, camice impermeabile, maschera filtrante, visor, doppio paio di guanti – come astronauti, distanti anni luce dagli altri esseri umani, o come palombari che emergono dagli abissi. Le parole stesse stentano a passare attraverso la barriera della maschera. Per non parlare dell’esclusione della comunicazione non verbale, che nella normalità trasmette più informazioni delle parole stesse. Le tute, impenetrabili al virus, sembrano esserlo anche alle parole e soffocare i sentimenti.
E che dire dello sguardo? Nella situazione di isolamento creato dall’emergenza, sembra essere restato il canale privilegiato. Diversamente da quanto avviene nella cura in condizioni di normalità. Faceva notare acutamente la linguista Lucia Fontanella, proponendo riflessioni sulla comunicazione in ambito clinico sulla base dei propri ricordi ospedalieri: “Se siete stati in ospedale, soprattutto da malati, avrete notato quante strategie sanno usare i medici e gli infermieri per non incrociare lo sguardo dei pazienti. Hanno paura di essere ‘arpionati’, hanno paura di una domanda, hanno paura di incontrare le persone che sono i malati” (La comunicazione diseguale, Il Pensiero Scientifico 2011). Ancor più provocatoriamente, Pino Roveredo nel romanzo Ci vorrebbe un sassofono (Giunti 2019) mette in bocca a una paziente la domanda pungente rivolta con cortesia al suo medico: “Scusi se mi permetto, sa per caso di che colore sono i miei occhi?”.
Siamo nell’ambito delle lagnanze tante volte ascoltate da parte dei malati nei confronti dei medici che per tutta la durata della visita non hanno mai staccato gli occhi dallo schermo del computer, dove erano riportati i dati clinici delle analisi a cui il malato è stato preventivamente sottoposto. L’emergenza della pandemia può avere questo insperato effetto benefico: distogliere i curanti dalla fascinazione crescente esercitata su di loro dalla comunicazione digitale, per riportarli sul terreno solido di una cura che passa attraverso i sensi.
La vista in primo luogo. In competizione con l’udito: perché l’ascolto è il primo atto di un processo comunicativo. Precede la parola e l’accompagna nella conversazione. E naturalmente il tatto, a cui affidiamo il bisogno di vicinanza, soprattutto quando le risorse terapeutiche hanno toccato il fondo e il bisogno prevalente è quello di essere accompagnati nell’ultimo tratto di strada. È allora che la medicina scopre quanto l’high touch prevalga sull’high tech.
Ciò vuol dire che la medicina che emerge sarà ostile al potenziamento offerto dalla tecnologia? Tutt’altro. Lo utilizza, ma con creatività, non dimenticando i bisogni fondamentali di chi accede alle cure. Uno dei medici che offre la sua testimonianza non esita a dichiarare che la sua “vera medicina 2.0” è quella che lo induce a prestare il suo telefonino a un paziente per videochiamare un parente rimasto a casa e permettere loro di salutarsi un’ultima volta, offrendo al malato la possibilità di morire un po’ meno solo; poi disinfetta il cellulare, per prestarlo al successivo paziente.
Questa pratica della cura, antica e nuova insieme, è quanto affermano di aver imparato i quattro medici torinesi che hanno vissuto lo sconvolgimento portato dalla pandemia. Malgrado la distanza imposta dalla protezione di sicurezza, hanno scoperto un’intimità con i malati che nella normalità è considerata inappropriata. Fino a permettersi di piangere e proclamare, rivolti idealmente ai pazienti: “Se vedrete le nostre lacrime, sappiate che non sono di burn out né di frustrazione: stiamo esattamente dove dobbiamo e vogliamo essere e abbiamo gli strumenti per affrontare la pandemia. Piangiamo perché capiamo cosa provate e soffriamo con voi. Le nostre lacrime sono le vostre lacrime”.
Hanno imparato a riconoscere le proprie paure. Hanno scoperto che si può sorridere con gli occhi. E che, imbozzolati nelle tute, possono abbracciare con lo sguardo. Un sapere prezioso, fatto affiorare dall’emergenza. Ci auguriamo di vederlo mettere in pratica anche quando tornerà la normalità. Perché offrire un rapporto di cura è molto più che rendere possibile una guarigione. E’ questa la buona medicina, di ieri e di domani.
L’abbracciare con lo sguardo acquista a questo punto un significato ulteriore. Oltre a caricare il rapporto con il malato dell’intensità che nasce dal praticare la medicina con i cinque sensi – anche se è l’occhio che assume il compito di rappresentare gli altri sensi impossibilitati a partecipare – l’abbraccio attraverso lo sguardo rimanda, in senso figurato, alla capacità di contenere in un unico atto visivo tutti gli aspetti di una questione. È quello che facciamo quando “abbracciamo con lo sguardo”, da un punto di vista più alto, panorami frastagliati, realtà diverse e magari contraddittorie.
L’emergenza ci ha condotto ad adottare uno sguardo che abbracci tutti gli aspetti dell’arte della cura: la mobilitazione delle risorse terapeutiche appropriate come l’accettazione del limite; fare tutto il possibile quanto sapere quando astenersi; l’intensità delle cure insieme alla palliazione, intesa come un’attenzione “simultanea” ai bisogni che accompagnano tutto l’arco del processo terapeutico; il curare come il prendersi cura. Una sfida impossibile? I medici dell’ospedale torinese con la loro testimonianza ci dicono che questo sguardo sono riusciti ad attivarlo anche nel tempo dell’emergenza. Ci sentiamo autorizzati a sperare che possa diventare realtà anche dopo l’emergenza, in regime di cure mediche in condizioni di normalità. Ovunque.