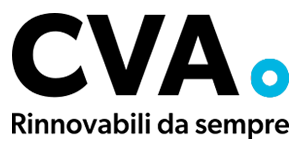Riportiamo il testo integrale dell’intervento del Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini presso l’Associazione Bancaria Italiana in occasione dell’inaugurazione del Corso di Alta Formazione.
Che eredità lasceremo alle prossime generazioni? La “sfida della sostenibilità” consiste appunto in questa domanda. Tra i tanti che si potrebbero scegliere, vorrei concentrare l’attenzione su due argomenti che a me paiono particolarmente importanti: l’ambiente e la finanza pubblica. Questa coppia di questioni all’apparenza così distanti è unita infatti dal tema della sostenibilità. Come le cose fatte di chi ci ha preceduto hanno lasciato a noi, in entrambi i casi, una non facile eredità, così le politiche di oggi determineranno in larga misura il fardello che peserà sulle spalle di chi ci segue.
In entrambi i casi, le azioni degli ultimi trent’anni hanno consentito di segnare passi avanti importanti (in tema di finanza pubblica penso tra l’altro alla riforma delle pensioni, compiuta per tappe nell’arco di vent’anni; ci tornerò), ma la strada da percorrere è ancora significativa. In entrambi i casi, si deve scegliere tempo per tempo tra intervenire o rinviare – o, per essere più realistici, in che misura fare l’una e l’altra cosa: rinviare può sembrare oggi una scelta più facile, ma aggrava i problemi di domani. In entrambi i casi, ci può essere la tendenza, non solo a scontare a un tasso troppo elevato i costi futuri (cioè a dare troppo poco peso al benessere delle generazioni che verranno), ma anche a sopravvalutare la difficoltà di agire nel presente. In entrambi i casi infine, idealmente almeno, piuttosto che prendere misure draconiane nell’immediato, serve tracciare la rotta con chiarezza e mantenere, per quanto le condizioni lo consentono, un corso moderato e stabile nel tempo.
La condivisione dell’obiettivo e la perseveranza nel perseguirlo costituiscono il modo più efficace per scongiurare il rischio di dover poi adottare drastici e costosi provvedimenti di emergenza sotto la pressione di una crisi.
L’ambiente
In tema ambientale, ho dedicato in passato qualche riflessione alla transizione energetica e climatica; aggiungerò stavolta alcune considerazioni, in parte ma non solo legate al clima, sullo stato di salute più generale del nostro sistema naturale. Dovendo parlare di temi che esulano dalla mia specifica vocazione professionale, mi rifaccio ai risultati delle successive edizioni del Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, redatte dal Comitato per il capitale naturale, cui la Banca d’Italia partecipa fin dalla sua istituzione.
Dai rapporti più recenti ricavo che (usando le classificazioni e i criteri in essi adottati) su 85 categorie di ecosistemi analizzati, 29 risultano ad alto rischio; questi ecosistemi coprono in complesso il 39 per cento della superficie nazionale. Si tratta di aree in prossimità delle zone umide, della fascia costiera, delle pianure interessate da attività agricole e di allevamento intensivo. Un quarto delle specie di uccelli, si legge, è gravemente minacciata; quasi due terzi sono in uno stato di cattiva conservazione per la perdita di habitat, l’uso eccessivo di pesticidi e una pianificazione infrastrutturale che non tiene conto del rischio di alterazione, perdita e frammentazione degli habitat naturali. Per effetto di pressioni antropiche (impermeabilizzazione del suolo, depauperamento delle risorse ittiche, eutrofizzazione delle acque) viene considerato perduto il 30 per cento delle praterie marine. Le foreste italiane, tra le più ricche di biodiversità in Europa, sono colpite più frequentemente di un tempo da incendi, eventi metereologici estremi ed epidemie parassitarie. Il cambiamento climatico è uno dei principali di fattori di pressione sulla natura e sul benessere umano, ma ad esso si aggiungono altre cause: modifiche negli usi dei terreni, perdita di habitat, inquinamento, diffusione di specie invasive. Questi processi hanno contribuito a modificare la distribuzione delle specie, la dinamica delle popolazioni e il funzionamento di molti ecosistemi marini, terrestri e d’acqua dolce6. Quanto ciascuno di noi sia turbato da questo genere di fatti, quanta importanza attribuisca a essi rispetto ad altre finalità dell’agire umano, dipende da sensibilità e preferenze personali. Tuttavia, alcune notevoli conseguenze pratiche di trasformazioni e impoverimenti ambientali mal gestiti non possono lasciare indifferente neppure chi sia meno incline a dolersi per il cambiamento del paesaggio o per la minore varietà di uccelli e di pesci.
Un esempio concreto è rappresentato da quanto sta accadendo al ciclo delle acque. Non saranno sfuggiti a nessuno gli allarmi sulla portata dei fiumi italiani che ricorrono e si intensificano di anno in anno. Secondo elaborazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tra il 1991 e il 2020 la disponibilità idrica si è ridotta del 20 per cento rispetto ai valori storici; inoltre, “le proiezioni climatiche future evidenziano, sia su scala globale che locale, possibili impatti dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e sulla disponibilità di risorsa idrica, dal breve al lungo termine”. La tendenza è proseguita nel 2022 e si ripresenta anche quest’anno. Secondo l’Osservatorio siccità del CNR, la popolazione residente in aree affette da siccità severa o estrema è pari al 16 per cento se si considerano gli ultimi 24 mesi. Il Centro internazionale in monitoraggio ambientale rileva che l’acqua contenuta nella neve accumulata a livello nazionale fino ad aprile è inferiore del 64 per cento rispetto agli ultimi 12 anni. La situazione pare critica in particolare nel Nord: secondo l’Osservatorio risorse idriche dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI), ad esempio, nei primi due mesi dell’anno in Piemonte i volumi di pioggia e neve sono pressoché dimezzati rispetto ai valori medi degli ultimi anni, il che ha prodotto una critica riduzione delle portate di tutti i fiumi, con ovvi riflessi sull’intero sistema idrico settentrionale. Le ricadute di queste tendenze vanno dalle rese del settore agricolo (con potenziali effetti sui prezzi dei prodotti alimentari), al valore del turismo invernale, alla generazione elettrica. Quest’ultimo punto ha conseguenze pervasive sul sistema economico. Nel 2022 la produzione idroelettrica, la più importante componente dell’energia da fonte rinnovabile, è stata inferiore di circa il 40 per cento alla media del quadriennio precedente. Dati relativi ai primi mesi di quest’anno indicherebbero una prosecuzione della tendenza; se il fenomeno si prolungherà, al deficit occorrerà far fronte con altre fonti come il gas, con conseguenze su cui non occorre che mi soffermi.
Data la natura di questi fenomeni, spesso complessi, lenti e difficilmente reversibili, per affrontarli occorre la capacità di valutare con attenzione costi e benefici di ogni alternativa di azione, con una visione di lungo periodo, scevra da pregiudizi.
Quali che siano le preferenze personali in tema di ambiente, le risorse destinate a gestire la transizione ecologica e climatica sono anche un investimento economico. Poiché però la materia ambientale è caratterizzata per definizione da ampie esternalità, è difficile che le decisioni individuali producano da sole un livello appropriato di simili investimenti. Anche se coscienza e reputazione possono contribuire significativamente a influenzare il comportamento sia dei singoli sia delle imprese, non si può prescindere da politiche pubbliche appropriate. Tra esse rientrano sia misure di natura regolamentare, per esempio in materia di consumo del suolo, sia meccanismi che consentano di “internalizzare le esternalità”, ossia di fare entrare nel calcolo economico degli agenti le conseguenze ambientali delle proprie azioni: come sussidi, tasse, o meccanismi per lo scambio di diritti di sfruttamento delle risorse naturali.
Nel caso dell’energia e del clima, obiettivi quantitativi di lungo periodo sono stati stabiliti da tempo a livello internazionale ed europeo. Questa però, pur con tutte le ardue vicende negoziali che l’hanno contraddistinta, è stata in realtà la parte facile. La parte difficile consiste nell’attuare politiche per raggiungere questi obiettivi; e soprattutto perseverare nel tempo, anche di fronte agli sviluppi imprevedibili a cui ci si trova continuamente, inevitabilmente di fronte.
Serve un complesso di azioni, su cui non posso qui entrare. Dirò soltanto che uno degli elementi generalmente riconosciuti come necessari per influenzare nella direzione desiderata i comportamenti individuali di consumo e di investimento consiste nell’agire sul prezzo relativo dell’energia di fonte fossile, magari gradualmente, ma con sufficiente chiarezza circa gli obiettivi finali. In questo quadro si è inserita la crisi dell’anno scorso. Incidendo sui prezzi di gas e petrolio in modo imprevisto, improvviso e a tratti estremo, essa ha dato luogo a provvedimenti di ristoro in tutti i paesi, con il più che legittimo obiettivo di alleviare le difficoltà di famiglie e imprese. Con l’occhio a una strategia di lungo periodo che tiene conto del carbon pricing, tuttavia, in alcuni paesi europei si è cercato aiutare chi ne aveva bisogno senza sopprimere del tutto gli effetti allocativi dei segnali di prezzo relativo. In Italia la questione non ha ricevuto a mio avviso tutta l’attenzione che meritava nella discussione pubblica sui provvedimenti da adottare.
Come ho detto altrove, nel lungo periodo la decarbonizzazione del sistema energetico non solo non è in contrasto con il perseguimento della sicurezza strategica in materia, ma anzi la favorisce: riduce la dipendenza dell’Italia da fonti e fornitori specifici; isola almeno in parte la nostra economia dalla volatilità che caratterizza i prezzi delle commodities energetiche. Di essa abbiamo fatto dolorosa esperienza nel corso dell’ultimo anno e mezzo.
Secondo gli scenari elaborati dal Network for the greening of the financial system (NGFS), una rete di banche centrali, una transizione climatica tempestiva e graduale presenta costi e rischi considerevolmente minori di una transizione ritardata e da ultimo accelerata dal precipitare delle conseguenze di un riscaldamento globale incontrollato. Pur con l’intrinseca difficoltà di fare stime puntuali basate su scenari di lungo periodo, credo che sarebbe un errore non valutare adeguatamente questa prospettiva nel bilanciare le ragioni dell’agire e del rimandare.
Tutto quanto precede fa riferimento a politiche generali, a scelte che spetta alle autorità politiche compiere. Che ruolo resta per le banche centrali e per le autorità di vigilanza?
Le banche centrali europee, quali investitori istituzionali seppure sui generis, nelle proprie politiche di investimento tengono conto di criteri di sostenibilità ambientale, rilevati per quanto possibile in modo oggettivo e indipendente. Così fa dal 2019 la Banca d’Italia, che ha adottato nel 2021 una Carta degli investimenti sostenibili e pubblica annualmente un Rapporto in merito; da quest’anno, per decisione comune, tutte le banche centrali del SEBC si attengono, seppur con prassi operative diverse, a criteri simili nel dare conto dell’impatto sui rischi climatici dei propri investimenti non legati ai portafogli di politica monetaria. Credo sia appropriato che le banche centrali, con misura ed equilibrio, diano in questo campo un esempio concreto di “good corporate citizenship” e provvedano al tempo stesso a tutelare la sostenibilità dei propri investimenti a lungo termine. In tema di politica monetaria vera e propria, tuttavia, sono da tempo convinto che il primo contributo che essa può dare alla sostenibilità sia quello di favorire l’efficiente allocazione delle risorse nella direzione desiderata – posto che siano presenti i giusti segnali di prezzo e ogni altra misura necessaria per orientare le azioni degli agenti economici –, perseguendo efficacemente le proprie finalità di tutela della stabilità monetaria e finanziaria, condizioni chiave per il buon funzionamento dei mercati e del sistema dei prezzi. La BCE è impegnata a studiare le implicazioni del cambiamento climatico per la trasmissione monetaria e la stabilità dei prezzi e a tenere conto dei requisiti di sostenibilità ambientale nelle operazioni di politica monetaria; ha comunque sempre riconosciuto che la responsabilità primaria per le politiche ambientali rimane dei governi e dei parlamenti. Non credo che ci si debba aspettare che la politica monetaria possa dare di per sé un impulso significativo alla politica ambientale (o ad altre finalità socialmente meritorie), tramite la leva diretta di azioni selettive altamente discrezionali. Tra l’altro, le politiche ambientali sono il frutto di scelte a volte controverse e di delicati bilanciamenti di interessi. In democrazia, queste scelte spettano agli organi costituzionali che rispondono all’elettorato; non possono essere affidate a una tecnocrazia, quand’anche supposta “illuminata”, senza finire col metterne in discussione l’indipendenza.
Nella misura in cui si attueranno misure normative coerenti con gli obiettivi di lungo periodo, la risposta del mercato, incluso il mercato finanziario, non mancherà. Della capacità di un sistema basato su decisioni economiche decentrate di reagire con forza perfino nel breve periodo si è avuta a mio avviso una significativa testimonianza nel corso del 2022. Di fronte a una forte crescita dei prezzi finali del gas (pur con tutti i “ristori”) e a incertezze sull’approvvigionamento, i relativi consumi si sono ridotti del 9,5 per cento rispetto al 2021; la contrazione è stata particolarmente notevole nel settore industriale (-15,3 per cento), nonostante la tenuta dell’attività. A maggior ragione nel lungo periodo, se gli investimenti delle imprese e delle famiglie saranno orientati da politiche credibili, l’efficienza della produzione e del consumo nell’uso dei combustibili fossili aumenterà ancora.
Quanto alla regolamentazione e alla supervisione prudenziali, anch’esse a mio avviso devono attenersi, nella considerazione della sostenibilità ambientale, ai propri obiettivi istituzionali, in particolare la mitigazione del rischio delle istituzioni finanziarie.
È convinzione ragionevole, e a questo punto direi largamente condivisa, che l’evoluzione del clima comporti rischi, in particolare (seppur non esclusivamente) rischi di credito, che le banche e gli altri operatori devono prendere in considerazione insieme a tutti gli altri nelle proprie strategie gestionali. C’è in merito una letteratura ormai ampia, anche se costretta a fare i conti con i limiti delle verifiche empiriche su fenomeni nuovi, caratterizzati da effetti incerti e in parte lontani. Il Meccanismo unico di supervisione europeo (SSM) ha pubblicato nel 2020 aspettative di vigilanza in tema di rischio climatico per le banche “significative”, tornandovi anche successivamente; la Banca d’Italia ha fatto altrettanto nel 2022 per le banche più piccole e gli altri intermediari finanziari vigilati.
I rischi derivanti dalla perdita di biodiversità e da altri processi di degrado ambientale potrebbero anch’essi essere rilevanti; certamente interagiscono con i rischi climatici. Qualche primo tentativo di valutarli è stato fatto; l’NGFS ha inserito il tema nel proprio piano di lavoro, costituendo un’apposita task force a cui partecipa anche la Banca d’Italia.
In ogni caso, benché l’attenzione delle autorità di supervisione bancaria si sia finora concentrata sulle questioni climatiche, rischi ambientali più generali sono già menzionati nelle indicazioni di vigilanza che ho appena citato.
Le banche centrali e gli organismi di vigilanza cercano anche di contribuire al miglioramento delle informazioni circa le caratteristiche di sostenibilità delle attività in cui sono coinvolte le istituzioni finanziarie. La conoscenza è un presupposto necessario delle scelte; la disponibilità di adeguati standard di disclosure e di rating di sostenibilità è quindi importante. La questione, dibattuta ormai da anni per quanto riguarda i rischi climatici, non è facile da risolvere; potrebbe risultare ancora più complessa per gli altri rischi ambientali30. Qualche progresso comunque si è fatto, e nelle sedi internazionali si stanno ora definendo precisi obblighi di disclosure.
Il debito pubblico
La dimensione del debito pubblico italiano implica che una quota significativa delle risorse che lo Stato chiede ai contribuenti deve essere destinata ogni anno agli oneri per interessi, limitando perciò lo spazio di manovra delle politiche generali, ovvero riducendo la possibilità di allentare la pressione fiscale; espone l’economia e il sistema finanziario a rischi connessi con la fiducia dei mercati. Dal passato abbiamo ereditato un onere pesante. Quanto più saremo capaci di ridurlo, tanto minore sarà la quota di quest’onere che caricheremo sulle spalle delle generazioni future.
Il peso del debito cambia lentamente: non si può incidere su di esso in modo significativo e duraturo se non guardando a distanza. Non esistono scorciatoie né ricette miracolose. Servono piuttosto, in egual misura, ambizione e perseveranza. L’ambizione dovrebbe spronarci a stabilire obiettivi finali adeguati, tali da incidere significativamente sui gradi di libertà dell’azione collettiva; a non rassegnarci all’anomalia italiana di un debito tanto superiore alla media. La perseveranza consente di perseguire simili obiettivi senza sacrifici sproporzionati. L’indicatore di riferimento è l’avanzo primario, che può essere relativamente moderato purché sia persistente. Occorre in ogni caso sfruttare, con gli occhi rivolti al futuro, tutti gli spazi che offre la congiuntura; rifuggire dalla logica del “tesoretto”, da spendere spensieratamente ogni volta che l’andamento delle entrate o delle spese sia un po’ più favorevole del previsto; non rimandare sempre a tempi migliori l’inizio della cura.
Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano era poco meno del 145 per cento del PIL. Si tratta di un valore elevato, sia nell’esperienza storica, sia nel confronto internazionale. Nel biennio 2021-22, dopo il picco della pandemia, l’incidenza del debito sul prodotto è diminuita complessivamente di circa 10 punti percentuali, principalmente per effetto di un differenziale negativo (cioè favorevole) tra l’onere medio del debito e il tasso di crescita nominale del prodotto (“r-g”). Questo effetto ha più che compensato il disavanzo primario, su cui hanno gravato la pandemia prima e la crisi energetica poi. Per l’anno in corso le valutazioni ufficiali e le più recenti previsioni della Commissione europea indicano un’ulteriore riduzione, frutto di un differenziale “r-g” ancora favorevole, seppure in riduzione, a fronte di un minore disavanzo primario.
I risultati conseguiti negli ultimi due anni sono dunque positivi, benché non ci abbiano ancora potuto riportare dove eravamo prima della crisi. (In questo, del resto, non siamo un’eccezione). Essi dovrebbero essere visti come l’avvio di un percorso di continua, significativa e duratura riduzione.
Il governo ha presentato la scorsa settimana il Documento di economia e finanza. Non sarebbe appropriato che io ne parlassi in questa sede; le valutazioni tecniche della Banca saranno riservate, come sempre, alla testimonianza parlamentare che ci è stata richiesta e che si svolgerà tra pochi giorni. Per questo sarò estremamente breve su questo tema. Mi limito a sottolineare ancora una volta il valore dell’ambizione e della perseveranza: i colleghi che interverranno in Parlamento delineeranno quelle che ci paiono le implicazioni concrete di questi principi in rapporto ai piani che il Governo si propone.
Viviamo indubbiamente in tempi difficili per la gestione dei conti pubblici: non solo a causa degli shock inattesi che hanno colpito l’economia globale dal 2020 e dell’incertezza legata oggi agli andamenti della guerra e dei rapporti internazionali, ma anche per l’improvviso rialzo dell’inflazione.
Quest’ultima influenza i conti pubblici attraverso diversi canali. Nell’immediato, la crescita nominale delle basi imponibili sostiene la dinamica delle entrate; le spese primarie seguono con ritardo, tra l’altro in ragione della struttura dei meccanismi di indicizzazione. Anche il rapporto tra debito e PIL, nel momento di impatto di un’inflazione inattesa, si giova – a parità di ogni altra cosa – dell’aumento nominale del reddito, che costituisce il denominatore del rapporto.
Non si tratta però di effetti duraturi. Nel medio termine, data la normalizzazione della politica monetaria, il ritorno dei tassi di interesse su livelli positivi, a lungo termine anche in termini reali, e la riduzione del bilancio delle banche centrali tenderanno ad accrescere la spesa per interessi rispetto ai livelli straordinariamente bassi degli anni passati, che erano dovuti a condizioni senza precedenti. La politica monetaria super-accomodante del recente passato non avrebbe potuto comunque andare avanti all’infinito, a pena di una resa all’inflazione. Sarà quindi necessario adattare i programmi finanziari a un ambiente di tassi reali “normali”, moderatamente positivi, tali tra l’altro da remunerare ragionevolmente i risparmiatori.
Guardando ai prossimi anni, e pur riconoscendo che ogni esercizio di questo tipo è soggetto ad ampi margini di incertezza e quindi solo esemplificativo, qualche simulazione compiuta su un orizzonte che arriva fino al 2035 può essere d’aiuto.
Ipotizzando che la crescita in termini reali sia dell’ordine dell’uno per cento all’anno e che il costo medio del debito cresca gradualmente dai livelli attuali a valori poco superiori al 4 per cento, un saldo primario anche decisamente inferiore ai livelli che il nostro paese conseguì nella seconda metà degli anni novanta, purché mantenuto in modo costante, basterebbe a realizzare una riduzione significativa del rapporto fra debito e PIL.
In una prospettiva ancora più di lungo termine, l’orizzonte che meglio si attaglia al tema di questo intervento, occorrerà poi tenere conto delle tendenze demografiche. Su questo terreno si gioca gran parte della sfida della sostenibilità prospettica della finanza pubblica e si possono inquadrare meglio i termini dell’equità intergenerazionale.
Le più recenti proiezioni demografiche dell’Istat prefigurano una forte riduzione della popolazione residente – e in particolare di quella in età lavorativa – connessa con dinamiche di natalità e mortalità; il fenomeno sarà compensato solo in parte dall’immigrazione netta. Mantenendo ferma la definizione di età lavorativa, il rapporto tra gli individui che vi rientrano e il resto della popolazione passerebbe da circa 3:2 nel 2021 a circa 1:1 nel 2050.
Anche alla luce di questi andamenti demografici, alla fine dell’anno scorso la Ragioneria generale dello Stato ha rivisto le proiezioni della spesa pubblica connessa con l’età della popolazione nel lungo termine. Queste erogazioni, attualmente su valori prossimi al 24 per cento del prodotto, crescerebbero fino a superare di poco il 25 per cento nel 2044; tornerebbero a diminuire negli anni successivi scendendo a circa il 23 per cento nel 2070, un valore simile a quello che si aveva prima della pandemia.
Il picco atteso per il 2044 riflette quello della componente più ampia di questo aggregato: le pensioni. Vorrei tornare a sottolineare l’importanza fondamentale che ha avuto il processo di riforma delle pensioni compiuto negli ultimi decenni nel moderare le erogazioni nel lunghissimo periodo, nonostante l’invecchiamento della popolazione, riducendo così l’onere che graverà sulle generazioni future, altrimenti proibitivo. Questo risultato è stato ottenuto con l’introduzione di un preciso legame tra contributi versati, vita attesa al momento del pensionamento e ammontare dell’assegno (“equità attuariale”), il che garantisce la solidità finanziaria del sistema pensionistico, fornendo un contributo decisivo alla sostenibilità prospettica delle finanze pubbliche. Di questo risultato credo che possiamo andare a buon diritto orgogliosi.
Purché si mantenga fermo il pilastro dell’equità attuariale, non è impossibile, volendo, introdurre elementi di flessibilità, sia in avanti che all’indietro, nell’età del pensionamento. Personalmente non vedo nulla di male nel prevedere una certa libertà di scelta individuale, che consenta di tenere conto delle circostanze e delle preferenze dei singoli e anche – se si evita di imporre vincoli inutili all’attività dei pensionati – di lasciare a ciascuno la possibilità gestire come meglio può un ritiro graduale dall’attività lavorativa.
Vi sono tuttavia, in materia di pensionamento anticipato, due limiti che non dovrebbero essere superati. Il primo è che l’anticipo non sia tale da ridurre il trattamento pensionistico individuale (dato il vincolo dell’equità attuariale) al di sotto di un livello sufficiente per consentire al pensionato/a di vivere una vita dignitosa, fronteggiare le avversità e non gravare indebitamente sulla collettività in conseguenza di scelte troppo imprevidenti. Il secondo riguarda la distribuzione della spesa pensionistica aggregata nel tempo. Nel caso in cui, introdotte regole più flessibili, molti decidessero di anticipare la pensione e pochi di ritardarla, anche se nel lunghissimo periodo l’equilibrio complessivo dovrebbe restare garantito grazie all’equità attuariale, per un certo numero di anni si determinerebbe una “gobba” nell’andamento della spesa tale da mettere a rischio la tenuta della finanza pubblica nel breve periodo. Ogni provvedimento del genere dovrebbe perciò essere ben calibrato per graduare opportunamente la flessibilità consentita, evitare di introdurre incentivi distorti e prevedere la pronta copertura di un eventuale aumento della spesa dovuto a maggiori flussi di pensionamento.
Finora ho parlato dell’Italia, ma vorrei sottolineare – a conclusione di questa parte – che “ridurre gli elevati rapporti debito pubblico/PIL in modo realistico, graduale e duraturo” e “promuovere una crescita sostenibile e inclusiva” sono precisamente gli obiettivi che persegue anche la proposta avanzata lo scorso autunno dalla Commissione europea per la riforma della governance economica dell’Unione. Il dibattito su questa riforma è in corso. Non deve essere presentato, come rischia di fare qualche semplificazione giornalistica, come il teatro di una battaglia retorica fra cicale e formiche. Avere un percorso credibile di rientro, sorretto da regole efficaci, è nel nostro interesse, tanto di breve quanto di lungo termine.
Conclusioni
Transizione ambientale e risanamento della finanza pubblica richiedono prima di tutto una chiarezza circa gli obiettivi più lontani; in secondo luogo, la consapevolezza delle azioni necessarie nel presente per conseguire quegli obiettivi; in terzo luogo, la continuità dell’azione nel corso degli anni.
Non l’austerità vorrei additare come bussola dell’agire politico, ma la razionalità e la lungimiranza.
Quali che siano le motivazioni profonde e le legittime scelte morali e ideologiche dei singoli, una società che investa oggi nella riduzione dell’incidenza del debito e nel contrasto al degrado ambientale non ha bisogno di invocare un’etica collettiva della rinuncia. La transizione ecologica, se affidata nella misura necessaria alla creatività e all’iniziativa del mercato, può, anzi deve, essere fonte di sviluppo anche economico e di benessere in generale; è la protezione ossessiva del vecchio, la battaglia di retroguardia a difesa dell’assetto produttivo esistente, che riduce le prospettive di occupazione e di reddito, non l’apertura al nuovo. Né vi è, contrariamente a quello che molti sembrano pensare, alcuna alternativa fondamentale tra crescita e rigore finanziario; al contrario, nel lungo periodo finanze pubbliche solide possono contribuire a sostenere il potenziale di crescita dell’economia grazie alla riduzione dell’incertezza che altrimenti graverebbe sulle decisioni di investimento e consumo. E infine, non può sfuggirci, neanche in un’ottica di breve periodo, che il debito pubblico è un peso ossessivo, un vincolo costante alla capacità di reazione delle politiche, un rischio sempre in agguato. Insomma un onere che altri non hanno, e che anche noi dobbiamo cercare seriamente di scrollarci di dosso.
Nessuno più degli operatori della finanza è cosciente della minaccia potenziale di instabilità legata all’eccessivo debito pubblico, così come del costo permanente rappresentato dalla sua espressione di mercato, lo spread sovrano. Se la consapevolezza del rischio climatico e degli altri rischi ambientali è più recente nel mondo bancario e finanziario, sono convinto che essa non tarderà a consolidarsi. Il lavoro che le banche stanno facendo, accompagnate dall’autorità di vigilanza, sulla valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e alla transizione energetica fa parte del loro mestiere.
Perseguire uno sviluppo sostenibile è una decisione di investimento economicamente razionale.
Se vi è, in aggiunta, una motivazione collettiva in senso lato etica, essa mi pare quella dell’equità intergenerazionale. Disse ormai molti anni fa, citando Virgilio, un Presidente del consiglio dei ministri nel sottoporre alla fiducia del Parlamento un programma di governo che affrontava una buona volta alcuni temi cruciali della sostenibilità finanziaria: “carpent tua poma nepotes”. I frutti degli alberi che pianti, li coglieranno i tuoi discendenti. Per guardare negli occhi i propri figli con la coscienza tranquilla, non c’è prospettiva migliore.