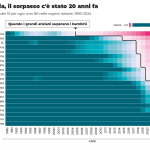La manovra delineata nel Dpb 2026 è prudente e coerente con il nuovo quadro europeo, imperniata sul rientro dell’indebitamento sotto il 3% già nel 2026 e sul rispetto della regola di spesa netta.
La traiettoria programmatica prevede deficit al 2,8% del Pil nel 2026, 2,6% nel 2027 e 2,3% nel 2028, con debito in lieve crescita nel 2026 (137,4%) e successivo calo fino a 136,4% nel 2028, trainato da un avanzo primario in rafforzamento.
Lo scenario macro resta cauto: crescita moderata, inflazione in progressivo riassorbimento verso il 2% e disoccupazione in lieve flessione.
È quanto rileva, in un’analisi flash sul Documento programmatico di bilancio, Unimpresa, dal quale emerge, sul piano delle misure, il taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% a sostegno del ceto medio e dei consumi, gli incentivi a salari e produttività (rinnovi contrattuali e premi di risultato) e l’agevolazione del trattamento accessorio nel pubblico impiego.
Per le imprese, la combinazione di ammortamenti potenziati, rifinanziamento di Contratti di sviluppo e Nuova Sabatini, e continuità dei crediti d’imposta in ZES/ZLS, configura un pacchetto coerente pro-investimenti, mentre la sterilizzazione di plastic e sugar tax fino al 31 dicembre 2026 evita shock di costo alle filiere.
Sul fronte sociale, rifinanziata la carta “Dedicata a te” (2026-2027), rivisto l’Isee e previste misure mirate per caregiver e lavoratrici madri.
In sanità, stanziati +2,4 miliardi nel 2026 e +2,65 miliardi annui nel 2027-2028 per personale e servizi, con potenziale impatto su liste d’attesa e produttività.
Le coperture si fondano sugli effetti della rimodulazione del Pnrr (nell’ordine di circa 5 miliardi nel 2026), su misure a carico del settore finanziario e assicurativo e su rimodulazioni della spesa.
Tra i rischi evidenziati: la necessità di chiudere la PDE mantenendo il deficit inferiore al 3% nel 2026, l’esecuzione tempestiva degli strumenti pro-impresa (Sabatini, contratti, ZES/ZLS) e la capacità amministrativa nella messa a terra del Pnrr.
La disciplina dei conti è condizione abilitante: la sfida è trasformare stanziamenti e incentivi in cantieri, investimenti e occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.
Secondo il Centro studi di Unimpresa, il Dpb 2026 delinea una traiettoria di bilancio improntata a prudenza e credibilità, con l’obiettivo esplicito di riportare l’indebitamento netto sotto la soglia del 3% già nel 2026 e consolidare il percorso negli anni successivi.
La logica di fondo è semplice: ancorare la politica fiscale alla regola di spesa netta, preservare un avanzo primario in rafforzamento e contenere la dinamica del debito, che mostra un lieve incremento nel 2026 per poi rientrare gradualmente.
In questo quadro, la disciplina di finanza pubblica non è presentata come un fine in sé, ma come condizione abilitante per ridurre il premio per il rischio, stabilizzare il costo del capitale e sostenere, per questa via, gli investimenti privati.
Lo scenario macroeconomico incorporato nel documento è cauto: crescita moderata, inflazione in progressivo riassorbimento verso il 2% e disoccupazione in lieve calo.
Non c’è scommessa su accelerazioni improvvise, ma una premessa di “crescita paziente” che richiede politiche coerenti lato offerta.
È qui che la manovra prova a intervenire, combinando misure sul lavoro e sul fisco delle persone fisiche con leve dedicate all’accumulazione di capitale delle imprese.
La riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% ha una valenza sia redistributiva sia di sostegno alla domanda interna, con effetti più avvertibili sul ceto medio.
Gli interventi su rinnovi contrattuali e premi di risultato rafforzano invece la componente legata alla produttività, mentre sul versante del pubblico impiego la parziale decontribuzione del trattamento accessorio punta a facilitare il rinnovo e la qualità dei servizi.
Per il tessuto produttivo, soprattutto per le PMI, la combinazione di strumenti è più rilevante del singolo provvedimento.
La maggiorazione del costo ai fini ammortamento per i beni materiali, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini e la continuità dei crediti d’imposta in ZES/ZLS costruiscono un pacchetto coerente: riducono il user cost of capital, accelerano le decisioni di investimento e orientano la spesa verso filiere e territori con maggiori potenzialità di catch-up.
La proroga della sterilizzazione di plastic e sugar tax fino a fine 2026 evita shock di costo su comparti esposti e, indirettamente, sostiene il potere d’acquisto in una fase in cui la domanda deve consolidarsi.
La manovra dedica attenzione anche al fronte sociale.
Il rifinanziamento della carta “Dedicata a te”, la revisione dei parametri Isee e gli interventi mirati per caregiver e lavoratrici madri compongono un mosaico che prova a tenere insieme inclusione e incentivi al lavoro.
Sul sistema sanitario, l’incremento di risorse per il 2026 e il biennio successivo risponde a due criticità: la riduzione delle liste d’attesa e il rafforzamento del personale.
Se queste risorse saranno rapidamente “spese bene”, l’effetto non sarà solo sociale ma anche economico, perché minori tempi di attesa incidono positivamente su produttività e partecipazione al lavoro.
Il capitolo delle coperture è costruito su più pilastri.
Da un lato la rimodulazione del Pnrr, con effetti di cassa e competenza che, se ben gestiti, possono liberare margini nel breve senza compromettere gli obiettivi di lungo periodo; dall’altro, interventi lato entrate che coinvolgono i comparti finanziario e assicurativo, accompagnati da una revisione selettiva di spese ministeriali.
La chiave, qui, è la capacità amministrativa: la differenza tra un esercizio contabile e un’azione di politica economica efficace la fa la velocità con cui gli stanziamenti si trasformano in cantieri, macchinari, assunzioni e servizi resi.
Per le imprese, i benefici potenziali passano dunque da tre canali.
Il primo è finanziario: un profilo di deficit credibile riduce il rischio Paese e sostiene la discesa degli oneri sul debito sovrano, con effetti di trascinamento sul costo del credito.
Il secondo è fiscale-regolatorio: ammortamenti potenziati, Sabatini e contratti di sviluppo abbassano il costo degli investimenti e riducono l’incertezza sul quadro di incentivi.
Il terzo è infrastrutturale e territoriale: ZES/ZLS e una migliore esecuzione del Pnrr possono creare contesti locali più favorevoli, soprattutto nel Mezzogiorno, a patto di accelerare autorizzazioni e tempi di spesa.
Restano naturalmente alcune sensitività.
La chiusura della procedura per disavanzo eccessivo dipenderà dal mantenimento dell’indebitamento sotto il 3% nel 2026; uno scarto negativo di crescita o una dinamica dei prezzi più debole del previsto ridurrebbero il cuscinetto, imponendo scelte selettive sulla composizione della spesa e degli incentivi.
Inoltre, l’efficacia delle misure pro-impresa è fortemente condizionata dalla macchina attuativa: ritardi nelle erogazioni, complessità amministrative e incertezza interpretativa possono comprimere il moltiplicatore degli interventi.
In sintesi, il Dpb 2026 propone una manovra coerente con il nuovo quadro europeo e orientata a un sentiero di crescita graduale ma più solida.
La leva fiscale sul lavoro e il pacchetto investimenti per le PMI vanno nella direzione giusta.
La priorità ora è trasformare la prudenza di bilancio in fiducia degli operatori, la fiducia in ordini e commesse, e le commesse in produttività.
La condizione necessaria è la rapidità dell’esecuzione: tempi certi su Sabatini e contratti di sviluppo, governance efficace delle ZES/ZLS, capacità di spesa Pnrr e una pubblica amministrazione in grado di accompagnare le imprese lungo il percorso.
Solo così la disciplina dei conti potrà tradursi in crescita tangibile per il Paese.